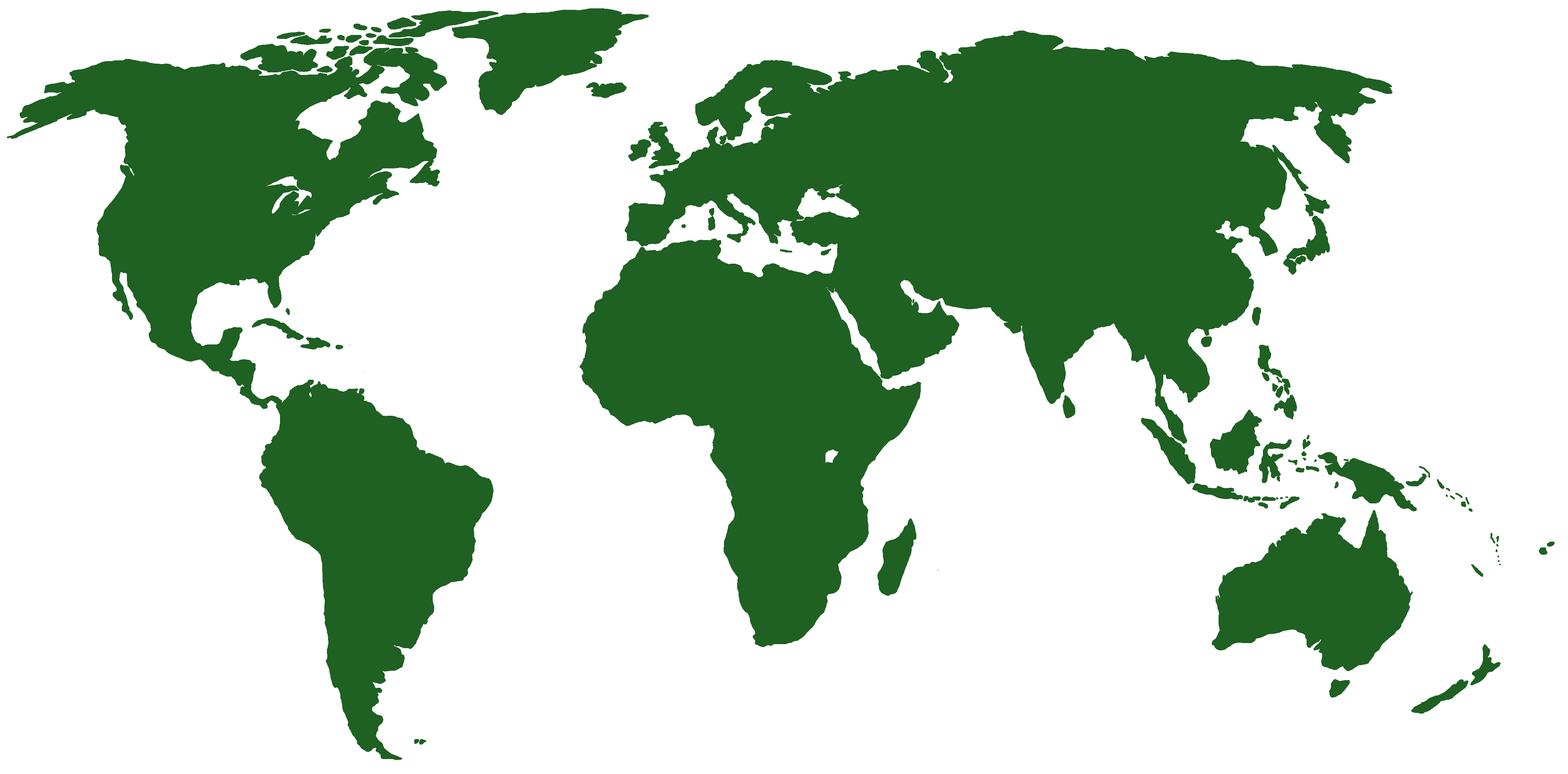Leggio Elettrico® (LE): apparecchio didattico-isocinetico per la lettura cartacea che migliora la visione e l’apprendimento
A cura di Domenico Carrella
con la collaborazione di Giulia Carrella* e Rosa Rianna*
Abstract
La funzione del Leggio Elettrico® nella metodologia didattica del TIO (Trattamento Integrato Oculare).
Il leggio elettrico® (LE) è una nuova tecnologia per la mente utilizzata per la somministrazione del TIO (Trattamento integrato oculare) che consente alle persone dislessiche, con deficit di decodifica su base visiva, di migliorare le prestazioni di lettura. Le funzioni dello strumento migliorano l'efficienza visuo-attentiva, la velocità ed il ritmo di lettura, con effetti positivi sull’apprendimento e la memoria. Al TIO si associa il principio visivo Carrella (PVC) composto da quattro elementi ergovisivi personalizzati: la posizione oculare alta (POA), la velocità costante di lettura (VCL), la direzione visiva centro-pagina (DVC-P) e la distanza di lettura massima (DLM), grazie al quale è possibile migliorare l'accessibilità visiva e la leggibilità del testo, cartaceo e digitale, sia dei lettori dislessici che ordinari. Ebbene anche per l’applicazione del PVC, il leggio elettrico® svolge un ruolo essenziale in quanto consente di utilizzare e mantenere in modo stabile sul testo i quattro elementi prima citati, in particolare la POA e la VCL che senza l’uso dello strumento non potrebbero essere applicati dal lettore in modo corretto, riducendone l'efficacia funzionale. Il leggio elettrico®, durante l’applicazione del Trattamento integrato oculare (TIO) della dislessia superficiale svolge un ruolo cruciale anche per il recupero delle funzioni neurovisive e lessicali, compromesse nel processo di lettura. Nel dislessico superficiale, a causa del deficit di decodifica su base visiva, la lettura risulta lenta, inaccurata e difficoltosa, in quanto la via lessicale essendo inefficiente (sia per causa congenita o acquisita) non consente di accedere correttamente al dizionario mentale della memoria visiva dove è depositato il significato delle parole, pertanto, compito del TIO è quello di “ri-attivare”, mediante il meccanismo di funzionamento dell’apparecchio, questa via deficitaria. Ciò avviene programmando lo spostamento del punto luminoso mobile-laser (PLM-L) in rapporto alla velocità di lettura del soggetto dislessico. Questo, di conseguenza, induce il lettore a seguire con regolarità e concentrazione il PLM-L sulla riga senza perdere il segno e soprattutto a mantenere costante la velocità angolare del movimento oculare. L’interazione occhi-PLM-L, che si manifesta in modo regolare durante tutto l’arco di svolgimento della lettura, produce la contrazione (accorciamento ed allungamento) dei muscoli oculari sia a velocità costante (isocinetica), sia a tensione o forza costante (isotonica). Questo tipo di movimento con velocità e forza costante, prodotto dalla contrazione dei muscoli estrinseci dell’apparato neuromuscolare dell’occhio, non riproducibile in natura ma solo con l’apparecchio, è alla base del principio riabilitativo “oculo-isocinetico” in grado di produrre effetti positivi sulla funzione visiva. Esso, durante la rieducazione oculomotoria con il leggio elettrico®, riduce, sui bambini in età evolutiva affetti da dislessia superficiale, le anomalie funzionali della muscolatura oculare di origine centrale responsabili della disfunzione visiva, che è alla base del deficit di decodifica lessicale e perciò del disturbo di lettura. Inoltre per favorire il processo di apprendimento delle parole concrete, la via visiva o lessicale deficitaria viene trasformata e potenziata in “via figurativo-semantica 3D”, mentre la via fonologica (che nella dislessia superficiale non è interessata dal disturbo) viene rafforzata mediante il “sistema di decodifica modulare” per facilitare la lettura e l'apprendimento delle parole astratte. Con la ri-abilitazione funzionale visiva ed oculomotoria, tramite l’apparecchio, si producono, durante le quattro fasi TIO, notevoli progressi nell'apprendimento della lettura, descritti nel testo DISLESSIA E RIABILITAZIONE VOL. I e VOL. II – Liguori Editore – Napoli (ITALIA).
1. Le vie di accesso alla lettura.
Nel normolettore entrambe le vie di accesso alla lettura, quella visiva (o lessicale) e quella fonologica (o non lessicale) funzionano in parallelo, per cui egli può utilizzare la via più adatta a seconda della parola che deve leggere. Nei soggetti con dislessia evolutiva superficiale o fonologica, invece, a causa di una condizione innata di origine neurobiologica, questo meccanismo non funziona correttamente: è efficiente soltanto una delle due vie di accesso al lessico, mentre nei soggetti con dislessia mista (superficiale e fonologica) sono deficitarie entrambe. Il deficit della componente visiva o fonologica o di entrambe interferisce nella capacità di decifrazione dei segni alfabetici e di decodifica e, conseguentemente, di comprensione e di apprendimento del testo scritto, causando rispettivamente la dislessia superficiale, fonologica o mista. Il trattamento proposto, visivo e cognitivo-linguistico, somministrato mediante la nuova tecnologia assistiva didattico-isocinetica del Leggio Elettrico®(LE), agisce specificamente sul deficit della decifrazione visiva della dislessia superficiale, determinando un notevole miglioramento della funzione visiva e della relativa decodifica del testo e, perciò, della lettura. Esso può essere applicato anche per la riabilitazione dalla dislessia mista e, nello specifico, per ridurre il deficit linguistico – visivo, mentre per quello linguistico - fonologico è richiesto il trattamento logopedico associato. Infine, per la riabilitazione dalla dislessia fonologica, di pertinenza del logopedista, il bambino può utilizzare lo strumento che rappresenta una risorsa aggiuntiva al trattamento applicato, in grado di facilitare la lettura ed accelerare anche il processo abilitativo/riabilitativo in oggetto.
2. Leggio Elettrico® (LE): costituzione, funzione e vantaggi per il lettore.
2.1 Costituzione e funzione.
Il Leggio Elettrico® è un nuovo apparecchio didattico-isocinetico per la lettura dei libri cartacei ed il trattamento delle disfunzioni visive e cognitivo-linguistiche dei soggetti dislessici. Esso, inoltre, può essere utilizzato anche dai lettori tipici per migliorare le prestazioni di lettura. Lo strumento è costituito da una base fissa che si appoggia sul tavolo e da un piano inclinato mobile (PIM) sul quale viene posto il libro, letto durante il suo spostamento lento verso l’alto. A fine lettura della pagina, il PIM arriva all'altezza programmata dove si ferma per poi ritornare in modo automatico e velocissimo verso il basso, riportando il libro alla base. Qui, il PIM arresta la corsa per poi riprendere di nuovo la salita lenta automatica (SLA), mentre il lettore prosegue la lettura sulla pagina successiva, seguendo il percorso lineare e programmato del PLM-L sulla riga. L'apparecchio è dotato di una tastiera con la quale si possono registrare e poi comandare i vari programmi di velocità di lettura, specifici sia per il normolettore che per il lettore svantaggiato o dislessico. Detto questo, precisiamo che la programmazione del tempo e quindi della velocità di lettura specifica (e anche delle pause di punteggiatura se si tratta di un lettore svantaggiato o dislessico), viene effettuata sul LE dopo essere stata individuata dall’operatore mediante un test preventivo, eseguito su un brano scelto in relazione all’età e alla classe frequentata dal soggetto. Quest’ultimo poi, dopo la registrazione dei dati sullo strumento, azionerà, mediante la tastiera, lo spostamento del PLM-L in relazione alla velocità di lettura ricavata dal test effettuato sul brano. La guida visiva del PLM-L, che si sposta sulla riga durante l'elettrolettura (v.nota 1), è costituita da un puntamento laser di classe 1 (innocuo) che, al pari di "un mirino di precisione", consente al lettore di:
- fissare l'occhio con attenzione sulla parola target e leggerla in modo accurato;
- guidare lo spostamento oculare sulla riga con movimento di tipo lineare anziché saccadico (a salto) tra un punto di fissazione e quello successivo della parola.
La programmazione del tempo di lettura con la corrispettiva velocità del PLM-L sulla riga è personalizzata. Essa può avvenire in due modi:
- per i lettori svantaggiati, lenti e dislessici, il movimento del PLM-L sulla riga è tendenzialmente continuo in quanto esso si ferma in corrispondenza dei segni della punteggiatura per il tempo previsto, per poi riprendere in automatico il suo spostamento sulla riga;
- per i normolettori, invece, il movimento del PLM-L sulla riga è continuo, no stop.
2.2 Vantaggi per il lettore.
La metodologia composta dal Leggio Elettrico® e dal Trattamento integrato oculare (TIO) mette in pratica alcune teorie, modelli, principi e tecniche di interesse medico-pedagogico per la riabilitazione dalla dislessia superficiale, che nel lettore migliorano anche il rapporto lettura e funzione visiva. Essa include:
a) la teoria del “doppio codice” o Dual Coding Theory, di Allan Paivio (1971, 1991);
b) il modello didattico della mascherina con finestrella mobile che funge da guida visiva manuale per la lettura dei testi cartacei introdotto da G. Geiger & J. Y. Lettvin (1999-2000);
c) il principio riabilitativo “oculo-isocinetico”, equivalente a quello “isocinetico-isotonico” delle apparecchiature elettromedicali isocinetiche;
d) il principio visivo Carrella (PVC) per la lettura ergonomica sia dei testi cartacei (letti sul LE) che digitali (letti sul video);
e) la tecnica di lettura ritmica per migliorare l'apprendimento dei testi scolastici e non.
Lo strumento, associato al Trattamento integrato oculare (TIO) e ad alcuni elementi ergovisivi introdotti nelle attività di studio, con il principio visivo Carrella (PVC), apporta ai soggetti dislessici diversi vantaggi per la lettura, la comprensione e l’apprendimento dei testi, descritti nei manuali "Dislessia e riabilitazione, Liguori Editore, vol. I e II, Liguori Editore". Essi sono:
a) vantaggi a breve termine di tipo
- cognitivo, con il miglioramento dell’attenzione, della concentrazione e del ritmo, prodotti dal corretto utilizzo dello strumento;
- ergovisivo, con riduzione dell'affaticamento oculo-visivo e mentale, derivante dall’assunzione della posizione oculare alta (POA);
- fisico-posturale, con il mantenimento di un buon equilibrio del sistema tonico-posturale, derivante dall’assunzione della postura corretta da studio (PCS);
b) vantaggi a medio e lungo termine di tipo
linguistico - visivo, con il miglioramento sia della lettura, in rapidità, correttezza e comprensione, sia dell’apprendimento, prodotti dal trattamento visivo e lessicale.
3. Teorie e modelli, principi e tecniche personalizzate, che, applicate mediante il Leggio Elettrico® (LE) ed il Trattamento integrato oculare (TIO), migliorano la visione e l'apprendimento della lettura ai dislessici.
3.1 La teoria del “doppio codice” o Dual Coding Theory, di Allan Paivio
(1971, 1991).
Essa è stata definita dagli scienziati una delle teorie cognitive più importanti del XX secolo, utile sia per i normolettori che per i soggetti svantaggiati. La teoria del doppio sistema di codifica, visivo e verbale, applicata tramite il supporto del Leggio Elettrico® (LE), migliora, durante la lettura delle parole, tradotte nelle relative figure (modificate dall’autore in forma tridimensionale 3D), sia l'apprendimento che la memoria di lavoro visiva e fonologica, carenti in tali soggetti.
3.2 Il modello didattico della mascherina con finestrella mobile, introdotto dagli scienziati neurocognitivi G. Geiger & J. Y. Lettvin (1999-2000) del Centro per l'Apprendimento Biologico e Computazionale del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Cambridge negli Stati Uniti, e quello equivalente della tecnica didattico-isocinetica personalizzata del Leggio Elettrico®.
Tale guida, riconosciuta ed approvata dal MIT, è costituita da un cartoncino o anche da un righello dotato di una finestrella di forma rettangolare di diversa lunghezza e larghezza che viene fatta scorrere a mano sulle righe della pagina via via che si leggono le parole al suo interno. Essa è stata proposta ed utilizzata dagli scienziati cognitivi del MIT, G. Geiger & J. Y. Lettvin (1999-2000), per aiutare le persone con problemi di lettura di natura visiva, causati dal ridotto mascheramento laterale (lateral masking), che impedisce loro di leggere correttamente le parole in visione centrale. La mascherina, durante lo spostamento sulla riga, migliora la lettura perché rende più agevole ed accurata la mira visiva, l’identificazione ed il riconoscimento delle parole del testo, consentendo di leggere solo la parola in visione centrale, cioè quella che compare nella finestra, coprendo tutte le altre a sinistra e a destra. Questo artifizio meccanico, semplice quanto efficace, utilizzato abitualmente per la riabilitazione dal Disturbo Centro-Periferia (DC-P), previene gli effetti negativi prodotti dal ridotto mascheramento laterale (lateral masking) responsabile delle fissazioni oculari decentrate, inaccurate ed imprecise, apportando un miglioramento della lettura per i soggetti trattati. Inoltre, a questo modello riabilitativo di lettura con la mascherina, gli autori americani hanno associato alcuni esercizi (mirati e personalizzati, che si possono praticare anche a casa da soli per circa 15-20 minuti al giorno, in circa 6 mesi) per migliorare la percezione visiva e la coordinazione oculo-manuale fine, ovvero le capacità prassiche. Detto ciò è d’obbligo riferire al lettore anche i vantaggi prodotti durante la lettura con la tecnica didattico-isocinetica personalizzata del Leggio Elettrico® per i soggetti affetti da dislessia superficiale, ottenuti grazie alla guida visiva automatica del PLM-L, che sfrutta:
a) il principio “oculo-isocinetico” simile a quello isocinetico-isotonico delle apparecchiature elettromedicali per la riabilitazione neuromuscolare;
b) il modello della guida visiva manuale della mascherina con finestrella mobile per la riabilitazione visiva.
La tecnica interattiva del PLM-L, che riproduce sia il principio che il modello citato, si è dimostrata utile per ridurre le disfunzioni dei muscoli oculari e le difficoltà visive di natura centrale.
3.3 Il principio riabilitativo “isocinetico-isotonico” delle apparecchiature elettromedicali isocinetiche e quello equivalente "oculo-isocinetico" del Leggio Elettrico®.
In questo paragrafo descriveremo, in sintesi, le analogie tra: a) le due apparecchiature isocinetiche; b) il disturbo neuromuscolare e neurovisivo; c) i due trattamenti, neuromuscolare e neurovisivo.
a) Analogia tra le due apparecchiature, quella isocinetica e quella del Leggio Elettrico® dotata di un principio di funzionamento equivalente.
Test scientifici eseguiti dai ricercatori hanno dimostrato che il principio isocinetico-isotonico delle apparecchiature elettromedicali isocinetiche offre notevoli vantaggi per la riabilitazione post-traumatica dei pazienti con disfunzioni o lesioni muscolari e anche post-intervento delle persone sottoposte ad operazioni chirurgiche. Queste apparecchiature per la fisioterapia neuromuscolare, usate nel campo riabilitativo e sportivo, consentono al soggetto, durante l'esercizio muscolare controllato, di sviluppare le contrazioni muscolari dinamiche con velocità angolare costante (isocinetica) e con tensione o forza muscolare costante (isotonica) per tutto l'arco dell’allenamento contro una resistenza accomodante, allo scopo di:
- potenziare la forza muscolare ed aumentare la resistenza alla fatica;
- riabilitare le lesioni muscolari e le relative disfunzioni.
Grazie al principio isocinetico-isotonico delle apparecchiature isocinetiche medicali, è possibile riabilitare, in modo efficace ed in tempi brevi (rispetto ai metodi tradizionali), lesioni muscolari provocate da sforzi eccessivi, da traumi o anche ridurre il periodo di convalescenza post-intervento. Utilizzando la tecnica equivalente personalizzata del Leggio Elettrico®, invece, è possibile trattare, tramite il principio riabilitativo “oculo-isocinetico”, le disfunzioni neurovisive e cognitivo-lessicali dei soggetti dislessici, con notevoli vantaggi di tipo visivo ed oculomotorio.
b) Analogie tra il disturbo neuromuscolare e quello neurovisivo.
Vediamo ora l’analogia intercorrente tra una disfunzione neuromuscolare provocata da una lesione che colpisce il muscolo di un arto e le disfunzioni neurovisive (visuo-percettivo-motorie) di lettura di origine centrale che si manifestano nel lettore svantaggiato. Nel primo caso si tratta di una lesione fisica da sforzo o da trauma che provoca una disfunzione neuromuscolare di un dato organo del corpo (esempio arto superiore, inferiore, ecc.) che impedisce, oppure limita al paziente, la regolare funzione dei movimenti. Nel secondo caso, invece, si tratta di disfunzioni neurovisive e motorie di natura evolutiva, prodotte da un insufficiente controllo dei muscoli dell'occhio da parte del cervello durante la scansione oculare sulla riga di lettura, associate al deficit di decodifica della dislessia superficiale. Tali disfunzioni, come B. Fischer et al. (2000) hanno dimostrato, sono caratterizzate dall'assenza di deficit visivi veri e propri, cioè di difetti visivi dell’occhio, di debolezza organica del tessuto dei muscoli extraoculari, nonché di lesioni, patologie neurologiche o ritardo mentale che potrebbero spiegare le difficoltà in oggetto. Sempre B. Fischer, uno dei massimi esperti e studiosi dei problemi neurovisivi legati alla dislessia evolutiva superficiale (DES), ha utilizzato la seguente metafora per indicare la causa del disturbo: "[...] non è guasta la macchina (i muscoli e gli occhi) ma il conducente (il cervello) a non saperla guidare [...]”.
Vediamo ora l’analogia intercorrente tra una disfunzione neuromuscolare provocata da una lesione che colpisce il muscolo di un arto e le disfunzioni neurovisive (visuo-percettivo-motorie) di lettura di origine centrale che si manifestano nel lettore svantaggiato. Nel primo caso si tratta di una lesione fisica da sforzo o da trauma che provoca una disfunzione neuromuscolare di un dato organo del corpo (esempio arto superiore, inferiore, ecc.) che impedisce o anche limita al paziente la regolare funzione dei movimenti. Nel secondo caso, invece, si tratta di disfunzioni neurovisive e motorie di natura evolutiva, prodotte da un insufficiente controllo dei muscoli dell'occhio da parte del cervello durante la scansione oculare sulla riga di lettura, associate al deficit di decodifica della dislessia superficiale. Tali disfunzioni, come B. Fischer et al. (2000) hanno dimostrato, sono caratterizzate dall'assenza di deficit visivi veri e propri, cioè di difetti visivi dell’occhio, di debolezza organica del tessuto dei muscoli extraoculari, nonché di lesioni, patologie neurologiche o ritardo mentale che potrebbero spiegare le difficoltà in oggetto. Sempre B. Fischer, uno dei massimi esperti e studiosi dei problemi neurovisivi legati alla dislessia evolutiva superficiale (DES), ha utilizzato la seguente metafora per indicare la causa del disturbo: "[...] non è guasta la macchina (i muscoli e gli occhi) ma il conducente (il cervello) a non saperla guidare [...]”.
Nei casi di dislessia acquisita superficiale (DAS), invece, il disturbo di lettura può essere causato da una patologia cerebrale come un ictus, da un trauma cranico o anche da una piccola lesione che può provocare nel soggetto colpito (bambino, giovane o adulto) conseguenze circoscritte in specifiche aree del cervello, danneggiando abilità visive, oculomotorie ed intellettive già apprese, come quella della letto-scrittura o del calcolo. Se, invece, il disturbo compare in età avanzata, esso di solito è causato dall’invecchiamento dei tessuti cerebrali o dell’apparato vascolare. Nei casi citati, cioè in presenza della dislessia acquisita superficiale (DAS) di natura organica, patologica o traumatica, la tecnica didattico-isocinetica personalizzata del Leggio Elettrico®, associata al TIO, può essere applicata solo dopo un’accurata valutazione neurologica da parte del medico specialista.
c) Analogie tra il trattamento neuromuscolare effettuato con le apparecchiature elettromedicali isocinetiche e quello neurovisivo con il Leggio Elettrico® associato al Trattamento Integrato Oculre (TIO).
Il trattamento neuromuscolare e quello neurovisivo e cognitivo-linguistico, effettuato con le rispettive tecniche isocinetiche, consente di ottenere identici benefici riabilitativi per le funzioni trattate. Nei pazienti con lesioni muscolari, le apparecchiature elettromedicali producono, attraverso l’applicazione di un programma di riabilitazione personalizzato, elaborato dall'operatore, un recupero stabile e veloce della lesione o disfunzione muscolare. Così anche per le disfunzioni neurovisive e cognitivo-linguistiche. Il LE, attraverso la tecnica didattico-isocinetica personalizzata che sfrutta sia il principio oculo-isocinetico che il modello della mascherina con finestrella mobile, produce un miglioramento oculomotorio, visivo e lessicale, in tempi legati alla severità del disturbo. In questo ultimo caso, il riabilitatore, attraverso il training visivo personalizzato con il Leggio Elettrico® (LE), persegue l'obiettivo di riabilitare o abilitare (a seconda se si tratta di un disturbo di lettura acquisito od evolutivo) le aree funzionali visuo-lessicali del cervello che risultano deficitarie. Questa tecnica viene applicata con un allenamento eseguito dal soggetto su schede di lettura, in relazione sia all’età che alla classe frequentata, nonché alla capacità mentale e alla formazione culturale.
3.4 Il principio oculo-isocinetico del leggio elettrico® (LE).
Il nuovo modus legendi del libro cartaceo, di tipo continuo o intermittente, mediante il piano inclinato mobile (PIM) e il punto luminoso mobile-laser (PLM-L) del LE, permette di leggere il testo con velocità programmata, costante e personalizzata, e contestualmente di controllare lo spostamento dell'occhio sulla riga con velocità costante (isocinetica) e con forza muscolare costante (isotonica). Grazie al mantenimento costante dei due parametri, che rappresentano gli elementi cardini del principio oculo-isocinetico del LE, è possibile controllare ed influenzare sia i fattori visivi-motori a basso livello come la velocità e la forza oculomotore, sia i processi cognitivi superiori come la velocità e la capacità mentale di leggere e apprendere. Durante la riabilitazione dal disturbo di lettura della dislessia superficiale o visiva, la metodica oculo-isocinetica dell'apparecchio, attraverso la regolazione ed il controllo costante della velocità e della forza oculare, riduce, sui bambini in età evolutiva, le anomalie funzionali (di origine centrale) dei muscoli extraoculari, responsabili delle disfunzioni visive ed oculomotorie, con un sensibile miglioramento sia dell'attività oculare che della lettura. Il visual-training oculo-isocinetico, calibrato sul dislessico superficiale, produce alcuni benefici visivi: 1) consente di fissare correttamente, con visione foveale (o centrale), le parole sulla riga di lettura; 2) riduce ed elimina le rifissazioni (è una seconda fissazione fatta sulla stessa parola a causa di una imprecisione della precedente saccade da sx verso dx); 3) riduce ed elimina le regressioni oculari, cioè le saccade di ritorno da dx verso sx dell'occhio sulla riga per rileggere una o più parole. Inoltre, mantenendo costanti e personalizzati, con il LE, i due pro-attivatori del principio oculo-isocinetico: il tempo di lettura ritmica e la corrispondente velocità, è possibile attivare correttamente anche il processo cognitivo superiore (composto da 7 elementi: l'attenzione, la concentrazione, la percezione, la comprensione, l'elaborazione, l'apprendimento e la memorizzazione). I benefici cognitivi dell'elettrolettura sono notevoli e tangibili per i lettori, ben superiori a quelli che si ottengono con la videolettura o con quella tradizionale, dove il tempo e la velocità non sono regolabili come, al contrario, accade con il LE. La terapia funzionale oculo-isocinetica viene somministrata per una durata di circa 2 anni, in età precoce, evolutiva, quando è possibile influenzare più efficacemente sia il sistema visivo che quello cognitivo. L’obiettivo della rieducazione funzionale, con la guida visiva, che scorre sulla riga con velocità costante e personalizzata, è quello di regolare, a livello centrale, le aree visive che controllano i movimenti oculari di lettura, cioè di riequilibrare e ridurre i disordini funzionali della visione che, per causa evolutiva o acquisita, risultano scorretti. Questo tipo di allenamento, che accresce il controllo dell'attività oculomotoria (fissazioni oculari e saccadi), è fondamentale per migliorare la lettura dei dislessici superficiali ed in generale anche quella dei lettori non dislessici che presentano difficoltà di lettura causate solo da disfunzioni visive.
3.5 Principio visivo Carrella (PVC) per la lettura ergonomica.
L'applicazione del principio visivo Carrella (PVC) per la lettura ergonomica dei testi cartacei e digitali prevede una visita specialistica oculistica preventiva per valutare nel soggetto sia lo stato di salute effettivo dell'apparato visivo, sia la funzionalità oculare e visiva per vicino, con l’eventuale prescrizione di lenti per la vista alla distanza di lettura massima (ved. Test di distanza progressiva*). Il principio visivo Carrella per la lettura, con la postura e la posizione oculare corretta da studio, consente l'accesso all'informazione scritta in modo semplice ed efficace con il più alto grado di ergonomicità oculo-visiva, mentale e posturale. La sua applicazione sul testo richiede l'impostazione di quattro elementi ergovisivi personalizzati con i relativi parametri di utilizzo:
1) la posizione oculare alta (POA*);
2) la velocità di lettura costante e personalizzata (VLCP);
3) la direzione visiva centropagina sinistra-destra (DVCPsx-dx) anziché quella tradizionale centrolibro;
4) la distanza di lettura massima (DLM).
Il principio visivo Carrella (PVC) per la lettura, unitamente ad altri elementi ergonomici, è stato descritto nel testo “Dislessia e riabilitazione”, Vol. II. Per l'applicazione dei primi due parametri, che rappresentano gli elementi cardine del principio visivo Carrella, cioè il tempo e la velocità di lettura costante e personalizzata (VLCP) e l'assunzione ed il mantenimento stabile della POA sul primo rigo del testo, è necessario l’uso del LE. La scoperta della POA ha avuto origine da una semplice intuizione relativa al“riflesso di Bell”, cioè al comportamento oculare in condizione di riposo, scoperto da Sir Charles Bell (1774-1842). Questo medico, anatomista e scienziato scozzese, è stato il primo a descrivere l’automatismo oculare, secondo il quale, quando la persona chiude gli occhi con le palpebre abbassate ed i muscoli oculari rilassati, i due bulbi oculari si spostano spontaneamente verso l’alto e all’esterno, assumendo la posizione di riposo o di rilassamento fisiologico. Studiando questo comportamento, l’autore ne intuisce l’importanza e le potenziali applicazioni nel campo della lettura e della prevenzione e riduzione dell'astenopia* (v.nota 3). Egli, infatti, scopre che, applicando e mantenendo la POA in modo stabile sul primo rigo, con l’uso del LE e l’applicazione degli altri elementi protodidattici del Modello di lettura ergonomica (MLE), producono nel lettore diversi vantaggi:
- una sensibile riduzione della stanchezza fisica dei muscoli oculari estrinseci ed intrinseci e, pertanto, dell'affaticamento oculo-visivo (ved. disturbo astenopeico) e mentale;
- un miglioramento della capacità cognitivo-linguistica di leggere e cognitivo-riflessiva di comprendere, elaborare, e memorizzare il testo.
Perciò, dopo averla sperimentata nei lettori di diversa età e capacità culturale, l'autore propone la POA per la pratica quotidiana della lettura anche ai soggetti svantaggiati affetti da dislessia o con semplici difficoltà. L'applicazione della POA, con l’asse visivo elevato sul testo (tra 15 e 30° circa), puntato sul primo rigo ad una distanza maggiore rispetto a quella tradizionale, con gli altri elementi ergovisivi associati alla lettura foveale (o centropagina), cioè con direzione visiva centrale sulla pagina e posizione simmetrica della testa rispetto alla stessa, sollecita un coordinamento sinergico ed equilibrato tra i due occhi. Il lettore, in questo modo, durante la lettura foveale con la direzione visiva centrale sulla pagina, ottiene la massima risoluzione delle parole o delle immagini che si producono sulla fovea centralis (posizione centrale della retina di massima acuità visiva), prevenendo anche l'affaticamento visivo e lo stress mentale. Questo comportamento visivo corretto induce i due emisferi, sinistro e destro del cervello, a lavorare in modo coordinato e sinergico con notevoli vantaggi sia per la prevenzione della stanchezza oculo-visiva e mentale, sia per il rendimento di lettura. La POA, pertanto, può essere utilizzata anche da coloro che eseguono lavori impegnativi o professionali sul video come tecnici ed informatici, ecc. o da coloro che svolgono di routine attività d’ufficio al PC. Secondo l'autore, il Modello di lettura ergonomica (MLE), con i relativi benefici prodotti dallo strumento, è destinato a sostituire per sempre il "modus legendi" scorretto del lettore tradizionale che generalmente è caratterizzato:
- dall’assenza di un metodo di studio;
- dalla posizione oculare bassa;
- dalla direzione visiva laterale (ved. centrolibro);
- dalla distanza di lettura ravvicinata al libro;
- dalla velocità di lettura incostante;
- dalla postura da studio scorretta;
- da ambienti di studio poco silenziosi, con fattori come il clima, l'umidità e l'illuminazione, non regolati correttamente che possono provocare frequenti interruzioni;
- dall'uso compulsivo degli strumenti tecnologici che inducono al multitasking riducendo il livello di concentrazione;
- dai tempi di studio e pause parking non personalizzate;
Inoltre anche il "modus operandi", ovvero la modalità di approccio alle attività di studio di questi lettori, è scorretta, in quanto si svolge mediante l'impiego di arredi tradizionali con sedie e scrivanie non ergonomiche, senza utilizzare alcun tipo di leggio. Lo studio, inoltre, si compie in ambienti spesso poco confortevoli, nei quali il clima, l'umidità e l'illuminazione non sono correttamente regolati, causando deconcentrazione ed improvvise interruzioni. Ma, a condizionare pesantemente la capacità di concentrazione e di apprendimento dei lettori nell’ambiente di studio o lavoro, è la presenza di rumori (interni o esterni: radio, televisione, telefoni, ecc.,), con l’uso compulsivo degli strumenti tecnologici, pc e smartphone, utilizzati per eseguire il multitasking, cioè per inviare o ricevere messaggi, navigare su siti internet, rispondere al cellulare, ecc. le cui distrazioni hanno effetti negativi sul cervello. Si tratta di effetti poco conosciuti, studiati e valutati, per cui ancora poco considerati dalle persone, ma che gli scienziati cognitivi ora stanno sottolineando e valutando con seria preoccupazione ai fini del rendimento nello studio o nel lavoro: “Dopo continue e improvvise interruzioni, il cervello, per riprendere l'attività sospesa e focalizzare in modo efficiente l'attenzione e la concentrazione sul contenuto del testo, richiede tempi specifici, variabili per ogni persona, da uno a diversi minuti e oltre …, specie se esse si manifestano in presenza di fatica e stress"..
La lettura parafoveale (o centrolibro), cioè con direzione visiva laterale sulla pagina e posizione asimmetrica della testa rispetto alla stessa, produce, diversamente dalla lettura foveale, una risoluzione visiva inferiore sulla fovea lateralis (posizione laterale o periferica della retina di minore acuità visiva), che induce, per automatismo, il sistema di elaborazione occhi-cervello ad intervenire continuamente sul testo per migliorare il meccanismo della visione. Questo sforzo aggiuntivo ed impercettibile, operato dal cervello, che compensa nei limiti il comportamento visivo scorretto del lettore tradizionale, contribuisce ad aumentare lo stress visivo e la stanchezza mentale. La lettura parafoveale, diversamente da quella foveale, sollecita principalmente il lavoro di un solo occhio (quello dominante) e, dunque, di un solo emisfero, quello controlaterale, causando sul lettore tradizionale un precoce sovraffaticamento oculo-visivo e mentale.
4. Educazione al ritmo per migliorare la lettura, l'apprendimento e la memorizzazione dei testi di studio, letti sul Leggio Elettrico® (LE).
Generalità.
La parola ritmo viene dal greco "rhythmos", che vuol dire "movimento misurato, flusso". Il ritmo di lettura rappresenta il movimento delle parole scandite con successione regolare ad alta voce sul testo, indipendentemente dalla velocità. I soggetti che, durante la lettura, hanno il senso del ritmo, cioè che riescono a coordinare, in modo cadenzato, l'alternanza delle pause della punteggiatura con i suoni del lessico, focalizzando tutta l'attenzione nell'andare a tempo sulle parole lette con intonazione, manifestano abilità superiori nell'ambito del linguaggio (letto, parlato e scritto) rispetto a quelli che, invece, ne sono carenti; ciò è stato dimostrato anche da una recente ricerca scientifica. Leggendo con uno specifico ritmo una frase, i lettori iniziano e concludono insieme la lettura, a tempo, cioè con una cadenza simile ad una armonia musicale; questo a prescindere dal tipo di velocità utilizzata (lenta, media o veloce). Pertanto, se durante la lettura di studio si rispettano il tempo, la velocità specifica e le relative pause, con gli stessi atti respiratori cadenzati, in corrispondenza della punteggiatura e si pronunciano le parole con la giusta espressione e gli stessi gesti, si genera, mediante la voce e le sue tonalità, anche il ritmo originario la cui perfetta riproduzione nella successiva lettura e ripasso orale ha una forte influenza sull'apprendimento del testo.
4.1 Caratteristiche del ritmo.
A) Definizione.
Per ritmo s'intende la regolare alternanza delle pause (attimi di silenzio del lettore di durata variabile) indicate dai segni di punteggiatura presenti all'interno della frase, con i suoni delle parole lette ad alta voce con espressività e tono adeguato al contenuto del brano.
B) Componenti costitutivi e stabilizzatori del ritmo.
1) I componenti costitutivi che attivano il ritmo di lettura sono:
- le pause di lettura, contrassegnate dai segni di punteggiatura della frase
- i suoni delle parole, ovvero gli elementi fonetico-fonologici del linguaggio.
Le pause di lettura.
Le pause di lettura, nell' ambito di una frase o di un testo, sono rappresentate dai segni di punteggiatura o di interpunzione: virgola, punto e virgola, due punti, punto, punto esclamativo, punto interrogativo, puntini di sospensione, ecc. La loro funzione è determinante durante la lettura per la comprensione del periodo e, quindi, del testo, per cui esse devono essere rigorosamente rispettate.
I suoni delle parole.
I suoni delle parole e la loro pronuncia, ovvero gli elementi fonetico-fonologici della lingua, rappresentano i mattoni dello sviluppo linguistico, quelli che il riabilitatore deve insegnare al bambino durante l'esercizio della pre-lettura e pre-scrittura per sviluppare la corretta comprensione ed acquisizione di lettere, sillabe e parole lette/scritte, ascoltate/pronunciate. Al discente, pertanto, va insegnato come acquisire e pronunciare correttamente, ad alta voce e con espressività, i suoni dei segni alfabetici; a modulare il volume ed il tono delle parole in relazione al significato della frase. La lettura ad alta voce, con suoni ben articolati,diversamente da quella silenziosa, aiuta il lettore a riconoscere e a migliorare la propria voce, a individuare più facilmente gli errori di pronuncia, grammaticali e refusi, la ripetizione o scorretta formulazione delle frasi, ma, soprattutto, a fissare le informazioni nella memoria, perché, come spiega lo psicologo Art Markman, professore di psicologia e marketing alla University of Texas: “Leggere a voce alta è un processo che impegna una parte della memoria diversa e più profonda rispetto a quella utilizzata con la lettura silenziosa”.
2) Componenti stabilizzatori del ritmo di lettura: lessicali e fisici.
Essi rafforzano l'espressione linguistica per cui la loro funzione è quella di contribuire a migliorare e a mantenere stabile il ritmo di lettura.
Elementi lessicali: il tempo e la velocità di lettura.
Gli elementi lessicali, stabilizzatori del ritmo, tempo e velocità di lettura, compreso l'elemento costitutivo, la pausa, possono essere programmati sullo strumento in modo personalizzato. Essi svolgono una funzione importante per lo sviluppo ed il miglioramento dei fattori cognitivi particolarmente carenti nei lettori svantaggiati, a causa dei quali manifestano serie difficoltà a leggere, apprendere e a memorizzare il contenuto del testo.
Elementi fisici: il gesto motorio e la respirazione.
Gli elementi fisici stabilizzatori del ritmo, il gesto motorio e la respirazione, vanno sviluppati dal discente, nella fase evolutiva con l'aiuto del riabilitatore. Il loro allenamento, infatti, contribuisce a facilitare nel soggetto il processo di apprendimento linguistico e a stabilizzare il ritmo.
Il gesto motorio.
Il gesto motorio spontaneo (il movimento delle mani prodotto dalla persona mentre parla) concorre a dare maggiore enfasi e vigore alla parola, sia letta che orale, ma, soprattutto, a stabilizzare l'evento ritmico durante le diverse fasi dello sviluppo cognitivo. Pertanto, il gesto spontaneo, pur connesso liberamente al linguaggio individuale del bambino, va moderatamente stimolato in quanto favorisce e rafforza l'espressione ritmica: “La riproduzione spontanea dello stesso gesto motorio si accompagna anche allo stesso ritmo che facilita l’apprendimento”. Il gesto, come ha scoperto la psicologa americana Susan Goldin-Meadow, dell'Università di Chicago, tramite esperimenti su gruppi di bambini: “Aiuta ad imparare e a memorizzare meglio i concetti in quanto stimolerebbe la mente”.
La respirazione.
La respirazione si compone di due fasi, l'inspirazione, quando l'aria viene introdotta nei polmoni consentendo alle cellule di assorbire l'ossigeno e l'espirazione quando l'aria viene espulsa dai polmoni, eliminando, così, l'anidride carbonica. Durante la lettura, la frequenza degli atti respiratori deve essere sincronizzata in relazione alla presenza delle pause brevi o lunghe di lettura indicate dai segni di punteggiatura. A tal fine gli esercizi di respirazione effettuati con la guida di un operatore, nel programma educazione al ritmo, hanno la finalità di sensibilizzare l’attenzione dell’allievo sulla corretta modalità di svolgimento di questa importante funzione.
L'esercitazione con la tecnica di respirazione addominale (o diaframmatica anzichè toracica), consente alle persone con o senza disturbo di lettura, di migliorare il dinamismo respiratorio durante il letto-parlato. Essa, infatti, consente di: 1) dosare volontariamente il fiato durante gli atti inspiratori e a controllare che essi siano regolari, graduati e lenti nella loro emissione, eliminando il respiro corto e disordinato; 2) aumentare la potenza respiratoria che consente anche un maggiore controllo fisico ed emotivo, riducendo il disagio e l'inadeguatezza del lettore poco esperto in questo compito; 3) migliorare sia l'ossigenazione del cervello che la voce. L'operatore, nella fattispecie, deve istruire il soggetto a rispettare i tempi e i modi di respirare durante la lettura di un brano. L'attività respiratoria va regolata in relazione al tipo di pausa di punteggiatura della frase Se si tratta di un punto posto alla fine della frase, si esegue la pausa lunga e contestualmente un profondo atto inspiratorio; invece, se si tratta di una virgola, ecc., allora si effettua una pausa breve con una minima espirazione. Questa norma, applicata durante la lettura, concorre allo stesso modo del gesto, a stabilizzare il ritmo, riducendo il senso di stanchezza fisica e mentale ed insieme la sensazione di ansia e di affanno che si manifesta nei lettori svantaggiati che mancano di ritmo. In sintesi, la regola da rispettare durante la lettura e l'eloquio è la seguente: “Prima della lettura di ogni frase di un brano o di una esposizione verbale di un periodo lungo, fermarsi per effettuare una regolare e profonda inspirazione. Proseguendo la lettura della frase, il lettore si fermerà sugli altri segni di punteggiatura (virgola, punto e virgola, ecc.) dove compirà brevi interruzioni, eseguendo, per ciascuna pausa, anche un piccolo atto espiratorio. Durante la lettura ad alta voce, rispettando le pause della punteggiatura in sincronia con gli atti respiratori, si contribuisce a stabilizzare il ritmo di lettura”.
4.2 Ritmo: significato e classificazione.
Significato.
Il ritmo rappresenta la componente "aurea" del linguaggio, quella che durante la comunicazione del messaggio, sia letto che parlato, introduce l'armonia e veicola con maggiore efficacia il suo contenuto all'ascoltatore o anche all'interlocutore. Viceversa, la mancanza di ritmo, sia nella lettura che nella comunicazione verbale, produce disarmonia, assenza di emozioni e di empatia. Il ritmo, nella lettura, varia a seconda a) al tipo di lettore (svantaggiato, normolettore, lettore professionista); b) al tipo di testo (letterario di narrativa, di studio o di apprendimento, cioè scolastico, universitario o professionale, di informazione come brochure, depliant, rivista, giornale, ecc.); c) alla modalità di lettura (cioè skimming* globale-orientativa o scanning* selettiva-esplorativa - v.nota 4/5).
Classificazione.
Il ritmo può essere classificato in: 1) dinamico; 2) stabile; 3) disarmonico.
1) Ritmo dinamico (o variabile).
Il ritmo dinamico si utilizza per la lettura di opere di narrativa (come romanzi, racconti di avventura, fantastici, ecc.), opere poetiche (poesie,prose,ecc.,), nelle quali la velocità di lettura può variare contestualmente al ritmo. In esse, il lettore deve adeguare il ritmo al contesto della lettura e, perciò, alle sequenze narrative del racconto che sta leggendo. Pertanto è giusto parlare di ritmi variabili: lentissimi, lenti, medi, veloci, incalzanti, concitati, che possono, di conseguenza, suscitare diversi tipi di emozioni sia nel lettore che nell'ascoltatore. Il ritmo dinamico, oltre a suscitare emozioni e rendere il brano più armonico e piacevole, è essenziale anche perché, durante la lettura, consente, al lettore e all’ascoltatore, di percepire e comprendere più facilmente il significato dei testi letti.
2) Ritmo stabile (o costante).
Il ritmo statico si utilizza nella lettura di studio per l'apprendimento dei testi scolastici, universitari o professionali, nei quali esso, insieme alla velocità di lettura, deve essere rigorosamente costante e personalizzato. La lettura di studio o di apprendimento, diversamente dagli altri tipi di lettura, dove il ritmo e la velocità possono variare in funzione dell'interpretazione reale o fantastica del suo contenuto, non richiede né enfasi, né valutazioni soggettive. Il suo contenuto, essendo istruttivo, formativo, ha un valore oggettivo per il lettore, ragion per cui il ritmo e la velocità devono essere stabili e personalizzati. Questo tipo di lettura, inoltre, richiede anche maggiore partecipazione emotiva, attenzione e concentrazione, talvolta protratta nel tempo appropriata al testo da assimilare, finalizzata alla comprensione, elaborazione, apprendimento e memorizzazione. Affinché la comprensione e l'apprendimento del testo sia efficace e funzionale, è necessario che il lettore imposti e mantenga, durante la lettura, la rilettura o il ripasso orale ad alta voce, il ritmo stabile e la velocità costante e personalizzata.
3) Ritmo disarmonico (privo di armonia).
Il ritmo disarmonico è caratteristico del lettore svantaggiato o dislessico, in quanto egli legge il testo di studio (o anche singole frasi) senza modulare la successione regolare dei due elementi che lo costituiscono: le pause e i suoni delle parole e rispettare le altre regole. Tale ritmo si può manifestare anche nel lettore tipico quando, in una fase preliminare alla lettura di studio e di apprendimento, legge il testo con modalità skimming globale-orientativa o scanning selettiva-esplorativa.
● Elementi di differenziazione tra i diversi tipi di ritmo: disarmonico, stabile e dinamico.
Leggendo due frasi di un ipotetico brano, dove sono presenti, tre virgole ed un punto finale nella prima frase e così anche nella seconda, è possibile rilevare diverse tipologie di ritmo.
a) Il ritmo disarmonico si manifesta se il lettore:
1) esegue la lettura con modalità skimming o scanning, cioè senza rispettare alcuna regola ;
2) non rispetta le pause relative alla punteggiatura delle frasi leggendo senza fermarsi;
3) effettua le pause ma fermandosi nei punti sbagliati, cioè non indicati dalle virgole o dai segni di interpunzione in una o in entrambe le frasi;
4) fa frequenti errori, ecc.
b) Il ritmo stabile si manifesta se il lettore legge le frasi di un testo di studio in modo armonico, rispettando, durante la fase di lettura, rilettura ed il ripasso orale, il ritmo e la velocità costante insieme agli altri elementi costitutivi e stabilizzatori.
Fase di lettura.
Il lettore legge le frasi del testo di studio rispettando tutti gli elementi (vedi) che danno ritmo alla lettura e ne facilitano la comprensione. Nel caso specifico: 1) rispetta il ritmo stabile; 2) mantiene il tempo e la velocità di lettura costante e personalizzata (lenta, media o veloce); 3) si ferma regolarmente in corrispondenza sia delle tre virgole della punteggiatura riferite alle pause brevi che del punto finale riferito alla pausa lunga, dove esegue anche la relativa inspirazione, ripetendo queste operazioni anche per la successiva frase; 4) utilizza la giusta tonalità della voce accompagnata dai gesti naturali che la rafforzano.
Fase di rilettura e ripasso orale.
Il lettore per produrre lo stesso ritmo stabile, durante le successive fasi di lettura e ripasso orale del testo, deve rispettare rigorosamente tutti gli elementi che lo compongono, prima enunciati.
c) Il ritmo dinamico si evidenzia se il lettore legge un brano narrativo (anziché di studio) in modo armonico, variando, in rapporto al suo contenuto, il ritmo e la velocità di lettura e rispettando tutti gli altri elementi costitutivi e stabilizzatori. Egli, nella successiva lettura del brano e ripasso orale, riproducendo tutti gli elementi armonici, è in grado di elaborare lo stesso ritmo dinamico, che può avere analogie simili a quello di un brano musicale. Di questo ritmo, gli speaker, i lettori professionisti, gli attori di cinema e di teatro sono maestri impareggiabili: durante le loro performance ne decantano bellezza ed armonia.
4.3 Il leggio elettrico®: quando utilizzarlo.
Il suo utilizzo per la lettura è rapportato al tipo di lettura.
a) Il leggio elettrico® è inadatto per la lettura dei testi di narrativa in quanto il lettore deve:
- leggere variando continuamente la velocità a seconda delle caratteristiche del contesto narrativo;
- padroneggiare i ritmi, differenziandoli a seconda della struttura, del significato e delle sfumature del testo;
- comprendere ed interpretare il pensiero dell'autore, cogliendone sia le sfumature che i particolari.
b) Il leggio elettrico® è inadatto quando si leggono testi a carattere informativo (depliant, riviste, giornali, ecc.) che: 1) non richiedono una particolare concentrazione mentale; 2) presentano spazi discontinui all'interno della pagina, con righe non perfettamente allineate al corpo del testo e l'impaginazione grafica con caratteri diversi,
c) Il leggio elettrico® è inadatto quando si leggono testi con modalità skimming e scanning, dove invece il ritmo è disarmonico (o assente).
Lettura con modalità skimming: globale-orientativa.
La lettura skimming, globale-orientativa è mirata alla ricerca globale e veloce sul testo di informazioni utili: le cosiddette parole chiavi, cioè titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, tabelle, elenchi, indici, parti evidenziate graficamente sul testo, ecc., utili per farsi un'idea orientativa dell'argomento generale, mentre il resto viene scorso rapidamente.
Lettura con modalità scanning: selettiva-esplorativa.
La lettura con modalità scanning è svolta in modo esplorativo, “a balzi”, in cui il lettore si sofferma in modo selettivo soltanto quando trova l'informazione che sta cercando, cioè che ha attratto la sua attenzione durante la fase esplorativa del testo.
d) Il leggio elettrico®, al contrario dei casi precedenti, è utile per la lettura di studio o di apprendimento del testo scolastico, universitario o professionale, cioè quando occorre mantenere un ritmo statico specifico con velocità costante e personalizzata.
4.4 Potenziamento del ritmo: il ruolo del riabilitatore e la funzione del leggio elettrico®.
a) Il ruolo del riabilitatore.
Il suo ruolo nel trattamento delle semplici difficoltà di lettura o del disturbo di lettura (dislessia), relativamente al programma di educazione al ritmo, è quello di:
- insegnare all'allievo gli elementi fonetico-fonologici della voce attraverso i quali egli impara a leggere bene e ad apprendere con "cura e attenzione” il testo, pronunciando le parole ad alta voce in modo corretto e veloce, con esatta decodifica delle lettere, rispetto delle doppie e pronuncia degli accenti tonici;
- controllare che il discente, durante la lettura, rispetti sia gli elementi fisici come la gestualità e gli atti respiratori, sia i parametri programmati sul leggio elettrico® (LE) come il tempo, la velocità e le pause.
Il lettore, con lo sviluppo ed il rispetto degli elementi costitutivi e stabilizzatori del ritmo, impara ad immergersi con la mente ed il corpo totalmente nel testo e ad eseguire anche una lettura efficace e funzionale, grazie alla quale egli acquisisce, nel corso dell’attività scolastica o riabilitativa, una maggiore consapevolezza per questo compito, sviluppando la velocità ed il ritmo di lettura che gli è più congeniale.
b) La funzione del leggio elettrico® (LE): i vantaggi per la lettura di studio e di apprendimento dei testi scolastici, universitari e professionali, prodotti dal ritmo stabile e dalla velocità costante e personalizzata
Il leggio elettrico® (LE), tramite le funzioni del punto luminoso mobile-laser (PLM-L) e del piano inclinato mobile (PIM), favorisce lo sviluppo e il rispetto di alcuni elementi costitutivi e stabilizzatori del ritmo di lettura, quali:
- la velocità costante e personalizzata di lettura del testo;
- il tempo di lettura programmato sul testo;
- le pause di lettura (brevi e lunghe).
La funzione del LE aiuta concretamente a sviluppare sia i due elementi lessicali velocità e tempo, sia a rispettare le pause di lettura. Ottimizzando questi elementi con l'uso dello strumento, si può aumentare la soglia di attenzione, di concentrazione e di percezione del lettore sul contenuto della lettura, migliorando la comprensione, l'elaborazione, l'apprendimento e la memorizzazione dei testi scolastici, universitari e professionali. Detto ciò, si ribadisce che, qualsiasi tecnica di studio il lettore applichi durante la lettura, senza il supporto strategico della componente ritmica, i risultati relativi all'apprendimento e alla memorizzazione dei testi saranno sempre inferiori alle aspettative. Per quanto concerne, invece, il trattamento riabilitativo del soggetto con difficoltà o disturbo di lettura su base visiva, il riabilitatore può stabilire e pianificare un training neurovisivo personalizzato tramite il LE. Esso, in questo contesto, svolge un ruolo essenziale sia per i lettori svantaggiati facilitando l'apprendimento della lettura, sia per i lettori tipici, aumentandone le prestazioni.
Produzione e rispetto, durante la lettura, la rilettura e il ripasso orale degli “stimoli ritmici fotocopia”: attivatori e potenziatori della memoria.
Dopo aver chiarito quanto sopra, possiamo affermare che l'apprendimento e la memorizzazione si possono migliorare e potenziare a condizione che il lettore, durante la lettura di studio di una frase o di un brano, la rilettura ed il successivo ripasso orale dello stesso, rispetti:
- le pause di punteggiatura con gli atti respiratori cadenzati in relazione ai segni di interpunzione della frase;
- i tempi e la velocità di lettura costante e personalizzata rapportata alla comprensione;
- la voce ed il tono utilizzando la stessa espressione in relazione al suo contenuto, accompagnata dallo stesso gesto.
La riproduzione del ritmo stabile e personalizzato che si ottiene rispettando tutti gli elementi descritti, consente l'esatta rielaborazione cognitiva delle informazioni acustiche, visive e cinestesiche acquisite. Esso, durante la ripetizione del messaggio, stimola, in specifiche aree cerebrali, l'attività sinaptica dei neuroni a produrre e ad elaborare engrammi* (v.nota 6) che si depositano nel magazzino della memoria di lavoro. La loro riattivazione, mediante gli “stimoli ritmici fotocopia” (inducono i neuroni specifici a produrre, mediante le sinapsi, gli stessi engrammi), consente che il messaggio appreso e depositato temporaneamente nella regione dell'ippocampo* (v.nota 7) possa essere “ripescato” e riportato alla mente. Il ricordo, in questo modo, può essere più facilmente recuperato e trasferito dalla memoria di lavoro (o a breve termine) alla memoria di medio e lungo termine dove permane per molto tempo. Il meccanismo teorizzato dagli scienziati è pressappoco il seguente:“Un segnale che passa attraverso le connessioni sinaptiche tra gruppi di neuroni, in qualche modo, vi lascia una traccia che rende più facile il richiamo dello stesso messaggio in un momento successivo attraverso l'attivazione delle stesse sinapsi. L'apprendimento del messaggio, pertanto, sembra essere influenzato dalla quantità di passaggi dello stimolo nervoso attraverso le sinapsi dei neuroni che dipendono dal numero di ripetizioni effettuate”. In merito a tale teoria, l'autore ritiene che, per migliorare l'apprendimento, oltre al numero delle ripetizioni utili in tal senso, sia necessario anche associare ad esse il ritmo stabile e personalizzato. La lettura e la ripetizione orale del messaggio, mediante la corretta riproduzione ritmica degli elementi che lo compongono, consente di stimolare in profondità le aree funzionali del cervello preposte alla elaborazione e all'acquisizione delle informazioni. Così, quando nella fase di ripetizione dell'informazione si ripresenta alla mente lo stesso ritmo iniziale, esso, stimolando lo stesso gruppo di neuroni e sinapsi, riporta alla luce anche il messaggio associato. Pertanto è poco meno che un postulato sostenere che il ritmo specifico, associato alle ripetizioni letto-verbali ad alta voce, svolga un ruolo cardine di attivatore e potenziatore di memoria.
.
5. I vantaggi della tecnica didattico-isocinetica personalizzata del Leggio Elettrico® (LE), associata al Trattamento integrato oculare (TIO) per i dislessici superficiali: la riduzione delle disfunzioni neurovisive con il miglioramento della decifrazione e relativa decodifica.
Premessa.
Nei soggetti con dislessia superficiale si evidenzia un disturbo di decifrazione dei segni alfabetici con difficoltà di accedere al lessico attraverso la via visiva e a riconoscere e comprendere i segni grafici delle parole che provocano una prestazione deficitaria nella lettura. L’arresto nell’acquisizione delle competenze visive della lettura, in età evolutiva, causa, in età evolutiva, difficoltà nella identificazione e discriminazione delle lettere, sillabe e parole (deficit di decifrazione), ma salvaguarda, nei limiti della norma, la componente fonologica (la via non lessicale della lettura), la decodifica dei grafemi in fonemi, tale da escludere il deficit fonologico e, quindi, l’intervento logopedico. Il deficit in oggetto, che interessa specifiche aree cerebrali che elaborano la visione e controllano in modo insufficiente sia le fissazioni che i movimenti oculari saccadici, infatti, impedisce al cervello del dislessico superficiale di:
- trasformare, comprendere e apprendere correttamente, nelle aree corticali deputate alla visione, le immagini visive delle lettere, sillabe e parole del testo;
- controllare con precisione l'attività oculomotoria (fissazioni e saccadi) sulla riga.
5.1 La riduzione del Disturbo Visuo-Percettivo (DV-P).
Il Disturbo Visuo-Percettivo (DV-P), che si manifesta con la difficoltà del soggetto di acquisire lo stimolo visivo (lettera, sillaba, parola) sulla riga e di elaborarlo correttamente nelle aree visive del cervello, causa frequenti errori visuo-percettivi di lettura. Esso, diversamente dalle ametropie o difetti visivi dell’occhio che possono essere facilmente corretti dallo specialista con lenti adeguate, richiede una diversa strategia di intervento basata sull’allenamento visuo-cognitivo. Il problema percettivo, che ostacola il riconoscimento e la discriminazione di una lettera quando essa è circondata da altre lettere, dando al lettore l'impressione che si sovrappongano, si evidenzia durante l'affollamento visivo (visual crowding). Infatti, questi soggetti confondono facilmente lettere graficamente simili come d/b, p/q, n/m, ecc., manifestando anche facile stanchezza oculo-visiva e mentale. Tale disfunzione, come sappiamo, è responsabile sia della lentezza che dell’inaccuratezza nella lettura. Il punto luminoso mobile-laser (PLM-L) del Leggio Elettrico® (LE), durante il training visivo didattico-isocinetico personalizzato, tende a ridurre l'effetto crowding e a normalizzare gli aspetti percettivi della visione, aumentando, durante la lettura, la capacità visuo-cognitiva di fissare e discriminare lettere, sillabe e parole e di elaborarle nel cervello.
5.2 La riduzione del Disturbo Oculomotorio (DOM).
Gli occhi, durante la lettura non si muovono in modo lineare lungo la riga di testo, ma compiono una serie di piccoli movimenti saccadici (a salti) inframezzati da pause di fissazioni, durante le quali avviene la lettura e, quindi, l’acquisizione delle informazioni lette. Detto ciò, i dislessici superficiali o visivi, durante il lavoro seriale da sinistra a destra, manifestano un disordine "continuum", legato alla difficoltà di specifiche aree visive del cervello di controllare sulla riga di lettura sia le fissazioni che i movimenti oculari saccadici (deficit oculomotorio), in posizione, direzione e velocità, originando il cosiddetto "errore motorio". Questi lettori, infatti, perdono facilmente il segno lungo la riga o al passaggio da una riga all'altra, oppure, durante il movimento oculare saccadico, non perfettamente calibrato da un punto di fissità a quello successivo della parola, saltano facilmente qualche termine, il che impedisce loro di comprendere il senso della frase. Inoltre, hanno difficoltà a fissare correttamente la parola bersaglio e a mantenere regolarmente lo stimolo visivo (lettera, sillaba o parola) sulla fovea centralis. Una volta accertata la disfunzione dei muscoli extraoculari di natura centrale, essi, come tutti gli altri muscoli del corpo, possono essere allenati per migliorare la loro funzione. Queste disfunzioni oculomotorie, sia singole che associate alla dislessia, trattate con il supporto della mascherina con finestrella o con il puntamento del dito, di una matita o di una penna, che, durante la lettura, vengono spostate per “tenere il segno” lungo la riga e/o al passaggio da una riga all'altra, senza anticipare o saltare le parole, adesso possono essere più efficacemente trattate e corrette con la tecnica didattico-isocinetica personalizzata del Leggio Elettrico® che sostituisce ed automatizza le tecniche manuali citate, migliorando, nel lettore svantaggiato, l’abilità oculomotoria. G. Nelles et al. (2009) hanno dimostrato con le loro ricerche che, l’allenamento dei muscoli extraoculari, con una specifica ginnastica visiva, può migliorare i movimenti oculari saccadici e produrre perfino un effetto potenziante di tutte le funzioni neurologiche centrali.
In precedenza, allo stesso modo, il Prof. Dr. B. Fischer (2004) dell'Università di Friburgo (dove ha diretto il laboratorio dello sguardo del Centro di neuroscienze), aveva ottenuto sensibili miglioramenti della funzione visiva, adoperando sui bambini dislessici una semplice tecnica visiva manuale. In seguito ai risultati positivi ottenuti, egli aveva affermato sulla rivista scientifica Mente & Cervello (bimestrale maggio-giugno, n. 9, anno 2004), che: “I bambini dislessici, in realtà, a volte, hanno solo problemi di percezione o serve loro un sostegno per imparare a guidare lo sguardo!”
5.3 La riduzione del Disturbo Centro-Periferia (DC-P).
Geiger & J. Y. Lettvin (1999-2000) hanno scoperto che molti bambini dislessici soffrono di un deficit legato ad un’alterata distribuzione spaziale delle risorse attentive e visuopercettive tra il campo visivo periferico e quello centrale. I due neuroscienziati, attraverso prove di laboratorio, hanno posto in evidenza che i dislessici, durante la lettura, anziché indirizzare le fissazioni oculari sulla posizione centrale della parola, puntano, invece, erroneamente, le parti periferiche della stessa. Essi, pertanto, possono identificare le lettere presentate alla periferia del loro campo visivo meglio di quanto non facciano i lettori comuni. Ciò succede perché questi soggetti, a causa dello scarso mascheramento laterale (lateral masking), hanno difficoltà ad inibire le informazioni provenienti dal campo visivo periferico che, di conseguenza, disturbano il processo di lettura svolto nel campo visivo centrale. Geiger e Lettvin hanno misurato su questi tipi di dislessici, mediante uno strumento di laboratorio, la distanza angolare, in gradi, dal centro dello sguardo verso la periferia, introducendo, nella diagnosi del disturbo, il FRF Form-Resolving Field (Campo di Risoluzione della Forma), un parametro che indica il disallineamento visivo centro-periferia, valutando i diversi gradi di eccentricità su entrambi i versanti del punto di fissazione. Inoltre, per la riabilitazione dal Disturbo Centro-Periferia, gli scienziati hanno introdotto la guida visiva manuale (di cui abbiamo riferito in precedenza). Questo modello di riabilitazione, proposto dai due scienziati neurocognitivi, è stato riprodotto ed innovato mediante la tecnica didattico-isocinetica personalizzata del Leggio Elettrico® (LE).
L'apparecchio, durante il training, tramite la guida visiva automatizzata del punto luminoso mobile laser (PLM-L), tende, in soggetti con DC-P, a regolarizzare il comportamento visivo, cioè il mascheramento laterale, migliorando la visione centrale e riducendo il campo visivo periferico allargato, responsabile della disfunzione visiva.
5.4 Il miglioramento della sensibilità al contrasto.
Nei soggetti dislessici che presentano una ridotta sensibilità al contrasto, il punto luminoso mobile laser (PLM-L) del leggio elettrico® (LE) viene trasformato in un rettangolo luminoso mobile-laser (RLM-L) e proiettato con un colore personalizzato sulla riga di lettura per aumentare il contrasto tra testo e sfondo e ottimizzare la leggibilità del testo. La scelta del colore da utilizzare è personale, per cui essa è fatta mediante un test preventivo. Il colore migliora la visione e perciò la qualità della lettura in quanto è dotato di due importanti proprietà:
a) cattura più facilmente l'attenzione del lettore sulle parole del testo;
b) produce la migliore visione possibile delle lettere, sillabe e parole.
Oltre alla scelta del colore, per migliorare la sensibilità al contrasto durante la lettura, è consigliabile anche l'individuazione dei caratteri più idonei, evitando quelli "con grazie", aumentando leggermente sia la loro grandezza, sia la spaziatura tra le lettere, le parole e le righe, rispetto a quella dei normali testi.
6. Le funzioni del leggio elettrico® (LE) e della relativa metodologia per migliorare le prestazioni di lettura dei soggetti svantaggiati, affetti dalla dislessia superficiale, con problemi di apprendimento cognitivo, visuo-percettivo e oculomotorio, stress e stanchezza fisica e mentale.
Per i soggetti affetti dai disturbi sopraccitati è difficoltoso mantenere l'attenzione e la concentrazione in modo costante sulla lettura senza distrarsi frequentemente dal testo. Essi, generalmente, presentano un comune denominatore: un indebolimento della funzione visuo-cognitiva con difficoltà ad elaborare le informazioni lette e memorizzarle. Il Leggio Elettrico®, durante la lettura dei testi cartacei, apporta, al lettore tipico e a quello svantaggiato, in relazione alla formazione ed agli obiettivi individuali prefissati, diversi benefici di tipo: cognitivo, percettivo e oculomotorio, antifatica e anti-stress, oltre a quelli ritmici di cui abbiamo riferito in precedenza.
6.1 Il miglioramento delle abilità cognitive di bambini con difficoltà d'apprendimento prodotto dalla nuova tecnica didattico-isocinetica interattiva del leggio elettrico® (LE).
I ricercatori Shulman et al. (1979) e Tsal (1983), analizzando con studi sperimentali lo spostamento del fuoco dell'attenzione nello spazio da parte di soggetti sottoposti a test visivi di lettura hanno esposto, in modo inconfutabile, dati a favore del movimento oculare a velocità costante.
La lettura di studio con velocità e tempo di lettura ritmica, costante e personalizzata, per l'apprendimento del testo, senza margini di errori in velocità, accuratezza e comprensione, può essere programmata e svolta solo con il supporto del leggio elettrico® . Lo strumento, tramite i due pro-attivatori, il tempo di lettura ritmica e la corrispondente velocità, è in grado di attivare, in modo lineare e sequenziale, i sette elementi del processo cognitivo (prima citati) che consentono di facilitare l'acquisizione delle informazioni lette sul testo cartaceo. L'aiuto, sia a livello visivo che cognitivo, che questa nuova tecnologia per la mente è in grado di fornire al lettore svantaggiato e non, per leggere e facilitare l'apprendimento dei testi, è rappresentato dalla individuazione e registrazione nella memoria dello strumento, del tempo di lettura ritmica (con il rispetto del numero delle pause e della loro durata) e della corrispondente velocità, monitorati passo passo sullo stesso. Grazie alla programmazione sul leggio elettrico® (LE) dei due parametri citati, i lettori dislessici, mediocri e normolettori, migliorano la performance di lettura.
Determinazione del tempo di lettura ritmica e della relativa velocità.
La velocità di lettura viene ricavata cronometrando il tempo di lettura impiegato dal lettore per leggere un certo numero di sillabe, parole, non parole, oppure di una o più frasi di un brano breve, medio e lungo. Esempio: se il bambino legge una frase costituita da 15 parole in 8 sec. e da due virgole di durata ciascuna di 1 sec., avremo un totale di 10 sec., che corrisponde al tempo di lettura programmato sul leggio elettrico® (LE). Il bambino in questo modo, seguendo lo spostamento del punto luminoso mobile-laser (PLM-L) sulla riga, è in grado di leggere la frase sempre con lo stesso tempo, cioè 10 sec. (di cui 8 sec. sono riferiti al movimento oculare e 2 alla somma delle due pause della punteggiatura dove l’occhio, in sincronia con il punto luminoso mobile, si ferma per il tempo programmato). Il rispetto di questi due parametri, tempo e velocità ritmica, consente al lettore di migliorare l'acquisizione delle informazioni lette sul testo. Relativamente al rapporto velocità/comprensione ed elaborazione cognitiva delle informazioni lette, vale la regola condivisa dagli scienziati neurocognitivi, secondo la quale, aumentando fino ad un determinato valore la velocità di lettura del lettore, compatibilmente con la comprensione e l'elaborazione cognitiva delle informazioni lette, si migliora l'apprendimento e la memorizzazione. Diversamente, la lettura con la velocità lenta, incostante e aritmica, tipica dei lettori mediocri o peggio ancora sillabata dei dislessici, ha effetti diametralmente opposti sulla comprensione, sulla elaborazione cognitiva e sull'apprendimento. Per una maggiore delucidazione in merito, ricordiamo che l'apprendimento cognitivo delle informazioni contenute nel testo scritto può avvenire correttamente solo se la velocità ed il tempo di lettura ritmica, costante e personalizzata, coincidono con la velocità e il tempo di elaborazione cognitiva delle informazioni comprese. Comparando il più possibile la velocità di lettura ed elaborazione cognitiva della comprensione, alla velocità del linguaggio orale utilizzato abitualmente, si migliora, nei lettori tipici, la performance di lettura e di apprendimento del testo. Diversamente si produce uno scarso rendimento nell'apprendimento e nella memorizzazione del brano letto. Infine, per ottimizzare il processo cognitivo di apprendimento delle informazioni lette, occorre individuare, anche un altro parametro: il tempo medio giornaliero che il lettore (dislessico e non) è in grado di dedicare alla lettura scolastica, universitaria o professionale. La sua individuazione, insieme con le relative pause tra la lettura di un brano e quello successivo, è importante per consentire al lettore di mantenere, durante la lettura giornaliera, un buon rendimento di apprendimento.
6.2 Il miglioramento visuo-percettivo e oculomotorio prodotto dal leggio elettrico® (LE), mediante le funzioni: a) del punto luminoso mobile-laser (PLM-L); b) del piano inclinato mobile (PIM).
A) Il miglioramento delle abilità visuo-percettive e oculomotorie prodotto dalla funzione del punto luminoso mobile-laser (PLM-L) del leggio elettrico® (LE).
L'accesso facilitato alla lettura da parte di bambini ed adulti dislessici che si affaticano facilmente a livello visivo e mentale, e con problemi di attenzione, concentrazione, percezione, comprensione, elaborazione, apprendimento e memoria, si ottiene mediante la funzione del PLM-L del leggio elettrico® (LE) , cioè trasformando la lettura tradizionale con movimenti oculari saccadici a scatti in lettura innovativa con movimenti oculari lineari e fluidi. Inoltre, l'elettrolettore dislessico elimina volontariamente anche i movimenti sx-dx e viceversa della testa che nella lettura tradizionale si accompagnano abitualmente agli spostamenti oculari sx-dx sulla riga. Durante il monitoraggio della lettura, confrontando i due tipi di movimenti oculari sulla riga, quello a scatto del lettore tradizionale con quello lineare dell'elettrolettore, si nota una netta differenza nel loro comportamento. Nell'elettrolettore, rispetto al lettore tradizionale, si constata, durante il processo “stop and go” di lettura, una diminuzione della fatica e, quindi, dello sforzo dei muscoli oculari estrinseci ed intrinseci, con un miglioramento dell'attività oculomotoria. In tale processo: a) "stop" rappresenta il punto di fissazione oculare della parola sulla quale gli occhi si fermano per circa 200 msec. per rilevare il suo contenuto ed inviarlo, tramite il nervo ottico, al cervello dove viene elaborato, compreso ed appreso; b) "go", invece, rappresenta il movimento oculare saccadico, a scatto, che dura circa 50 msec, durante il quale gli occhi, in assenza di visione, si spostano sulla riga da un punto a quello successivo della parola.
Il cervello esegue questo processo con tre operazioni in rapida successione:
- il disancoraggio, consistente nel distacco degli occhi dal punto di fissazione della parola target;
- la traiettoria, che rappresenta lo spostamento oculare saccadico sulla riga che ha inizio con il distacco degli
occhi dal punto di fissazione della parola target e prosegue mediante un movimento veloce, a salto (traiettoria), per raggiungere la parola vicina;
- l'atterraggio, è il punto di ancoraggio dove gli occhi effettuano la fissazione oculare sulla successiva parola target.
Sintetizzando, nella lettura tradizionale, gli occhi, comandati dal cervello, non si muovono sul testo in linea retta, continua, ma si spostano in modo ondulato su e giù da un punto di fissazione a quello successivo della parola,
in quanto i sei muscoli oculari estrinseci, quando si contraggono, spostano l’occhio a scatto, cioè con movimento oculare saccadico, avendo come punto di riferimento solo la riga. Nella lettura innovativa, invece, il concetto cambia radicalmente. L'avanzamento degli occhi sulla riga non avviene per “a scatto o salto” ma con movimento oculare "lineare e fluido", cioè uniforme e preciso.
Questa modulazione del movimento si produce grazie al principio riabilitativo “oculo-isocinetico” del LE. Durante l’elettrolettura, infatti, le contrazioni dei muscoli oculari che spostano l'occhio sulla riga, si producono sia a velocità costante (isocinetica), sia a tensione o forza costante (isotonica). Inoltre, gli occhi, seguendo in sincronia con il PLM-L il percorso lineare sulla riga, evitano al cervello una serie di operazioni aggiuntive, visive, mentali e fisiche che ne affaticano e rallentano l'attività. Durante la lettura, il movimento sincronizzato occhi-PLM-L apporta diversi vantaggi:
- produce una maggiore attività cerebrale. Il movimento, infatti, come dimostra l'esperimento descritto nel cap. IV - nel testo “Dislessia e riabilitazione”, vol. II - accende un numero maggiore di aree cerebrali che, di conseguenza, migliorano sia la concentrazione che le abilità visuo-percettive e cognitive;
- elimina le saccadi irregolari (regressive e involontarie sulla riga), in quanto gli occhi seguono l'andatura del puntatore senza distrarsi dal testo, riuscendo a "centrare" al primo colpo le parole bersaglio;
- migliora l'attività visiva e funzionale. È stato infatti dimostrato, come prima precisato, che gli occhi risultano più attivi, concentrati e precisi solo se possono seguire dei movimenti. Invece, senza inseguire nulla, essi risultano meno precisi e concentrati per cui si stancano anche più facilmente;
- facilita in modo regolare e costante la rotazione degli occhi nella cavità orbitale, evitando il carico di lavoro stressante prodotto dagli scatti, cioè dal meccanismo contrazione-rilasciamento operato dai muscoli extraoculari durante lo spostamento sulla riga, questo, di conseguenza, durante la lettura riduce lo stress visivo e mentale.
Inoltre, lo spostamento ergonomico degli occhi sul testo, che seguono passo passo in modo fluido e regolare il PLM-L, facilita anche il processo “stop and go”, descritto precedentemente. Infatti, analizzando lo svolgimento di tale processo (attivato con la tecnica del PLM-L), risulta che: a) il disancoraggio degli occhi dal punto di fissazione della parola avviene più agevolmente; b) la traiettoria, cioè il movimento degli occhi da un punto a quello successivo della parola, avviene senza che il cervello deve calcolare ogni volta i parametri dello spostamento oculare sulla riga: ampiezza, direzione, velocità e durata. Questo perché il movimento oculare tra i due punti di fissità è di tipo lineare; c) l'atterraggio sul punto di fissazione della successiva parola target si compie con maggiore precisione (prevenendo le saccadi irregolari e migliorando anche la decifrazione e la decodifica).
Per una valutazione generale dello stress e della stanchezza visuo-percettiva oculomotoria, prodotta sia durante la lettura tradizionale che in quella innovativa, si può effettuare un semplice calcolo, relativo sia al numero delle fissazioni oculari (FO), sia dei movimenti oculari prodotti durante i due tipi di lettura. Mediamente, il numero delle FO effettuate dal lettore tradizionale per ciascuna riga si aggira su 8, seguite da 7 movimenti oculari saccadici (MOS); se si fa un calcolo complessivo su 40 righe solitamente presenti in una pagina, sia delle FO che dei MOS, avremo che egli compie sulla stessa, circa 320 FO e 280 MOS. Mentre su 30 pagine lette giornalmente, questi compie circa 9600 FO e 8400 MOS. Con l'elettrolettura, invece, salvaguardando le 9600 FO sulle parole, sono eliminati gli 8400 MOS sostituiti con movimenti oculari continui (MOC) o lineari che riducono sensibilmente la stanchezza visuo-percettiva ed oculomotoria correlata allo sforzo del movimento oculare "a scatto o salto". Detto ciò, precisiamo che tutti i lettori che utilizzano la guida visiva automatica del punto luminoso mobile-laser (PLM-L) possono migliorare la lettura a livello visivo, oculomotorio e mentale. Gli occhi, infatti, compiono sulla riga movimenti oculari continui (MOC), più scorrevoli e rilassati con fissazioni oculari (FO) più precise. Infine, per un quadro generale più ampio e dettagliato dei vantaggi prodotti anche dalle guide visive manuali, si rinvia il lettore ad un esperimento classico, quello del puntamento del dito, descritto dallo psicologo inglese Tony Buzan nel testo “Lettura veloce” e riportato anche dall'autore a p.28, nel testo Dislessia e Riabilitazione vol.II. Egli è stato tra i primi ad evidenziare i benefici visivi, oculomotori e mentali prodotti dalle guide manuali, mediante il movimento oculare continuo (MOC) al posto del movimento oculare saccadico (MOS), a scatto o salto, in assenza della guida.
B) Miglioramento visuo-percettivo e oculomotorio prodotto dalla funzione del piano inclinato mobile (PIM) del leggio elettrico® (LE).
Utilizzando la funzione del piano inclinato mobile (PIM) del leggio elettrico® (LE), gli occhi, durante la lettura, rimangono allineati sulla parola osservata e posizionati costantemente all'altezza della prima riga; ciò consente di eliminare i movimenti oculari alti-bassi. Il lettore, inoltre, eliminerà volontariamente anche i movimenti oculari alti-bassi e viceversa della testa che, nella lettura tradizionale, accompagnano abitualmente gli spostamenti oculari alti-bassi sulla pagina. In definitiva, durante l'elettrolettura, la testa del lettore rimane eretta ed immobile e questo migliora sia il controllo dello sguardo sul testo che la visione. Grazie alla eliminazione dell'angolo visivo verticale ß tot. *(v.nota 8), si ha una riduzione dell’attività dei muscoli estrinseci che presiedono il movimento oculare alto-basso. Durante l’elettrolettura del testo sul leggio elettrico®, il PIM, che sale lentamente portando il libro verso l’alto, consente di effettuare al termine della lettura di ciascuna riga l’ampia saccade di ritorno con la quale l’occhio "torna a capo", sulla riga sottostante, con movimento orizzontale, anziché obliquo, come avviene durante la lettura tradizionale. Le ampie saccadi di ritorno di tipo orizzontale, ottenute grazie al perfetto sincronismo tra le funzioni del PIM e del PLM-L, impediscono la formazione dei movimenti oculari alti-bassi (dal primo al secondo rigo e così via fino all’ultimo rigo della pagina) che invece vengono effettuati con le saccadi oblique dal lettore, durante la lettura tradizionale. Premesso ciò, dimostriamo con un semplice calcolo i vantaggi per la prevenzione e riduzione della stanchezza visuo-percettiva ed oculomotoria ottenuta con questa nuova tecnica di lettura. Mediamente il numero delle righe di una pagina si aggira in 40, per cui il numero delle ampie saccadi di ritorno oblique eseguite sulla stessa, durante la lettura tradizionale, corrisponde a 40, mentre su 30 pagine lette giornalmente egli compie circa 1200 ampie saccadi di ritorno oblique e perciò di movimenti oculari alti-bassi. Con l’elettrolettura, invece, le ampie saccadi di ritorno oblique sono sostituite con ampi movimenti oculari di ritorno orizzontali, che impediscono gli spostamenti alti-bassi sulla pagina di lettura e, di conseguenza, l’occhio rimane fermo all'altezza del primo rigo della pagina. Questo comporta, per l’elettrolettore, l'eliminazione dei 1200 movimenti oculari alti-bassi con una sensibile riduzione della stanchezza visuo-percettiva ed oculomotoria. In questo modo si prevengono i disturbi astenopeici, frequenti, invece, nel lettore tradizionale. L'elettrolettore, con l'azzeramento dell'angolo visivo ß tot., compie solo brevi spostamenti oculari orizzontali da sx verso dx e viceversa sulla riga, che danno origine alla formazione di un angolo visivo orizzontale α tot *(v.nota 9). Dalla lunghezza della riga dipende anche la grandezza dell'angolo visivo orizzontale α tot.: meno lunga è la riga (ved. pagina a doppia colonna a righe corte), minore è anche l’angolo α e, perciò, lo stress visivo ed oculomotorio del lettore e con esso la possibilità che perda il segno sulla riga.
6.3 Benefici antifatica antistress per la prevenzione e la riduzione dell’affaticamento fisico, visivo e mentale, prodotti con l'assunzione della postura corretta da studio (PCS) dinamica, tramite la sedia ergonomica (ergosedia®) associata alla posizione oculare alta (POA).
Ai vantaggi per la lettura prima descritti, ottenuti mediante le due funzioni del PLM-L e del PIM, bisogna aggiungere anche i benefici di tipo fisico, visivo e mentale, prodotti con l'assunzione della postura corretta da studio (PCS) associata alla posizione oculare alta (POA).
Viceversa, se durante la lettura si utilizzano, di routine, in modo statico e protratto nel tempo, posture scorrette da studio (PSS), esempio con il collo, le spalle chine e la testa ricurva in avanti sul libro e si applica la posizione oculare bassa (ved. posizione oculare bassa, POB), scorretta, con un impegno visivo ravvicinato sul testo, inevitabilmente il lettore, sia tradizionale che digitale, avvertirà in modo precoce la stanchezza fisica, visiva e mentale, riducendo di conseguenza i tempi di studio.
Al contrario, se il lettore, durante l'elettrolettura, utilizza la PCS davanti al libro, con la testa eretta posizionata simmetricamente rispetto allo spazio della pagina, la posizione oculare alta (POA) e gli altri elementi ergovisivi del principio visivo Carrella (PVC), si riduce l'affaticamento fisico, visivo e mentale. Questo nuovo modello di lettura ergonomica, prevenendo i disturbi astenopeici che si manifestano durante la lettura cartacea e digitale, soddisfa con criterio scientifico i fondamenti della disciplina ergonomica così come richiesto dall'International Ergonomics Association (IEA). Il modello di lettura in oggetto ha prodotto nel breve e medio termine su gruppi di lettori selezionati con specifiche difficoltà un miglioramento sensibile delle prestazioni di lettura, con una notevole prevenzione e riduzione del disturbo astenopeico. Quest’ultimo, come sappiamo, colpisce milioni di lettori in tutto il mondo, in particolare i videolettori, che utilizzano, per un tempo prolungato e in modo scorretto, la distanza di lettura dal video (ravvicinata), la postura, la posizione oculare e la direzione visiva.
L'astenopia, inoltre, può colpire in modo minore anche i lettori tradizionali che utilizzano: a) posizioni oculari basse (POB), cioè con l’asse visivo inclinato sul testo cartaceo e asimmetrico rispetto alla pagina; b) posture scorrette da studio (PSS). In merito a tali posture il professor Kenneth Hansraj dello Spine Surgery and Rehabilitation Medicine (New York), nel 2014, ha svolto una accurata ricerca nella quale ha dimostrato che: “Quando la testa assume una posizione eretta, simmetrica al corpo, essa pesa circa 4 Kg, invece, con posizione inclinata in avanti sul testo (libro o smartphone), aumenta la pressione sulla parte cervicale del rachide e, di conseguenza, può variare anche il suo peso, da 27 a 60 Kg, in relazione ai gradi di inclinazione della testa”. Alla luce di quanto dimostrato, si può facilmente intuire l’utilità della posizione oculare alta (POA), che, per la sua caratteristica, induce il lettore ad assumere e mantenere davanti al testo anche la postura corretta da studio (PCS), prevenendo così l'assunzione di quella scorretta (con spalle, collo e testa curvi in avanti) con i relativi disagi, rilevati scientificamente dal professor Kenneth Hansraj.
7. I destinatari del Leggio Elettrico® (LE).
L'uso nelle scuole e nei laboratori didattici del leggio elettrico® (LE) con lettore interattivo laser, da parte degli studenti svantaggiati, favorisce il processo d'apprendimento linguistico nell'età evolutiva. Esso, pertanto, è destinato a:
- centri specializzati nel trattamento della dislessia ed agli specialisti della riabilitazione che prendono in carico i bambini con dislessia superficiale su base visiva o solo con disturbi visivi;
- insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria;
- genitori dei bambini dislessici;
- soggetti che presentano semplici difficoltà di lettura, in assenza della dislessia, cioè solo con disturbi neurovisivi di tipo: visuo-percettivo, centro-periferia, oculomotorio e di bassa sensibilità al contrasto, certificati dallo specialista;
- lettori comuni che vogliono semplicemente migliorare le prestazioni di lettura senza che abbiano alcun disturbo o difficoltà di lettura.
8. Ergosedia® per la lettura.
L’Ergosedia® è un arredo progettato per essere utilizzato, assieme al Leggio Elettrico® (LE), per le attività di lettura, ma anche davanti al PC per le attività professionali o d'ufficio. Essa consente, durante gli spostamenti posturali regolari e longitudinali sx-dx e viceversa, davanti al testo di lettura cartaceo o digitale, l'assunzione sia della postura corretta da studio (PCS) per prevenire ed alleviare il mal di schiena, sia della posizione oculare alta (POA) centropagina sx e poi centropagina dx (ved. terzo elemento del principio visivo Carrella), per prevenire e ridurre la stanchezza visiva, oculare e mentale.
Fruitori: studenti; professionisti; tecnici e lavoratori ai video terminali; impiegati, ecc..

Ergosedia® per la lettura.
L’ergosedia®, mediante alcuni elementi biomeccanici e funzionali di provata efficacia, che assicurano una postura corretta da studio (PCS), attiva e dinamica, procura al suo utilizzatore alcuni vantaggi:
a) facilita, durante la lettura sul LE, sul leggio di posizionamento meccanico (LPM) o davanti al PC, l'assunzione dell'atteggiamento mentale e oculo-posturale corretto da studio (AMO-PCS), cioè con postura corretta da studio (PCS), simmetrica davanti alla pagina di lettura e posizione corretta oculare (PCO);
b) previene ed allevia alle persone che svolgono attività sedentarie, d’ufficio, scolastiche o intellettuali, i problemi fisico-posturali quali mal di schiena, mialgia, correlate ad un irrigidimento di uno o più gruppi muscolari, da attribuire unicamente a stress da studio, da lavoro o all'assunzione di cattive posture, in assenza di traumi, strappi, distorsioni o patologie secondarie sottostanti;
c) consente, tramite piccoli e regolari spostamenti posturali orizzontali sx–dx e viceversa, effettuati sull’ergosedia, di puntare lo sguardo alternativamente sul centro della pagina sx e poi dx del libro. Tali spostamenti eseguiti a fine lettura, dalla pagina sx e a quella dx, facilitano l’assunzione del terzo elemento ergovisivo del principio visivo Carrella: “la direzione visiva centropagina sinistra-destra (DVCPsx-dx), anziché quella tradizionale centrolibro”. Tali movimenti, però, sono utili anche a prevenire condizioni di rigidità al collo e alla colonna vertebrale, con dolori ai muscoli e al corpo in generale, derivanti dalle posture immobili o passive frequenti durante le attività di studio o anche di lavoro sedentario, che le rendono difficili e faticose, specie nell’età dello sviluppo. Sintetizzando il pensiero condiviso da fisioterapisti e posturologi, si può affermare che: “qualsiasi postura risulta nociva se mantenuta a lungo durante lo studio o il lavoro, foss’anche una postura corretta!”. Ebbene, per prevenire tali rischi o alleviarne le conseguenze sulle persone, è consigliabile sia l’uso dell’ergosedia, sia eseguire, almeno ogni 30 minuti di postura fissa, una pausa di 2-3 minuti, nella quale svolgere semplici esercizi fisici e di "stiramento muscolare”.
Note
Nota 1: Elettrolettura.
Neologismo utilizzato dall'autore per qualificare una nuova tecnica di lettura interattiva, personalizzata, costante ed ergonomica del testo cartaceo, svolta sul LE. [torna al paragrafo]
Nota 2: Test di distanza progressiva per l’assunzione della Posizione Oculare Alta (POA).
Scopo di questo test è quello di individuare ed utilizzare la distanza di lettura massima (DLM) personalizzata, che consente al lettore di diminuire l’angolo visivo α (si forma tra l’asse visivo e i due punti estremi della riga) con riduzione della stanchezza oculare e di preservare il massimo comfort visivo anche durante la lettura prolungata. La sua esecuzione richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
a) la distanza di lettura dal testo cartaceo deve essere compresa tra 55 e 70 cm;
b) se si tratta di un soggetto che possiede la vista normale (emmetrope), la sua esecuzione avviene senza lenti;
c) se, invece, si tratta di un soggetto che possiede un difetto visivo dell’occhio (ametropia), il test viene eseguito con lenti prescritte dallo specialista ad una distanza prefissata tra 55-70 cm.
Per i bambini il test consiste nella lettura di una riga sul libro scolastico relativo alla classe frequentata, mentre per gli altri lettori (giovani e adulti), si utilizzano i libri abitualmente letti. Il libro viene posto su un leggio di posizionamento (cioè regolabile in diverse posizioni verticali e longitudinali) che consente di assumere la POA, elevata tra 15-30°, con la direzione visiva centro pagina sinistro-destra (DVCPsx-dx) ad una distanza iniziale di 55 cm. Dopo la lettura della prima riga ad una distanza di 55 cm si passa alla lettura della stessa riga ad una distanza di 60 cm, poi di 65 cm, fino a 70 cm. Se il lettore vede bene e legge la suddetta riga del testo alla distanza di 55 cm ed ugualmente bene a 60, 65 e 70 cm, si sceglie la distanza di lettura massima (DLM), compatibile con una visione nitida del testo, optando, così, per un giusto equilibrio dinamico tra l’acuità visiva e la distanza di lettura (entrambi importanti ai fini della prevenzione della stanchezza oculo-visiva). Davanti al PC si esegue la stessa prassi, utilizzando, però, distanze maggiori. [torna al paragrafo]
Nota 3: Astenopia.
Affaticamento oculo-visivo dovuto ad uno sforzo intenso e prolungato del bulbo oculare con sovraccarico lavorativo dell'apparato muscolare, cioè dei muscoli intrinseci ed estrinseci. [torna al paragrafo]
Nota 4: Skimming. Lettura con modalità skimming: globale-orientativa.
La lettura skimming, globale-orientativa, è mirata alla ricerca globale e veloce sul testo di informazioni utili: le cosiddette parole chiavi, cioè titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, tabelle, elenchi, indici, parti evidenziate graficamente sul testo, ecc., utili per farsi un'idea orientativa dell'argomento generale, mentre il resto viene scorso rapidamente. [torna al paragrafo]
Nota 5: Scanning. Lettura con modalità scanning: selettiva-esplorativa
La lettura con modalità scanning è svolta in modo esplorativo, “a balzi”. In essa il lettore si sofferma in modo selettivo soltanto quando trova l'informazione che sta cercando, cioè che ha attratto la sua attenzione durante la fase esplorativa del testo. [torna al paragrafo]
Nota 6: Engrammi.
Traccia mnestica prodotta nel sistema nervoso per mezzo di marcatori chimici che consente di apprendere e di mantenere il ricordo nella memoria. [torna al paragrafo]
Nota 7: Ippocampo.
La parte del cervello, situata nel lobo temporale, deputata alla trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine. [torna al paragrafo]
Nota 8: ß tot.
Si forma con la lettura tradizionale o anche digitale sull'asse verticale della pagina, sia cartacea che digitale, durante le escursioni dell'occhio dall'alto verso il basso, cioè dal primo all’ultimo rigo. [torna al paragrafo]
Nota 9: α tot.
Si forma tra l'asse visivo e i due punti estremi della riga. [torna al paragrafo]
*Hanno collaborato:
Giulia CarrellaDott.ssa in Lingue e Letterature Straniere Moderne, laureata presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, insegnante con esperienza decennale nell'applicazione di tecniche didattiche per l'educazione linguistica;
Rosa Rianna
Dott.ssa in Scienze della Formazione Primaria, laureata presso l’Università degli Studi di Salerno, insegnante di sostegno ed esperta nel trattamento della dislessia.
*Ringrazio:
Aldo De GioiaNapoletano, insigne pedagogista e già docente in diversi istituti culturali italiani, nonché conosciuto ed apprezzato nel nostro Paese come affermato scrittore.
L’amico Mario Esilio
per la copertina e i disegni che hanno arricchito i due volumi del testo “Dislessia e riabilitazione”.
Infine un ringraziamento va ai miei familiari e a tutti coloro (e sono tanti) che hanno creduto nel valore di questo progetto e mi hanno incoraggiato nel realizzarlo.